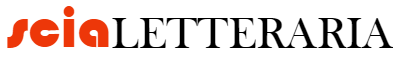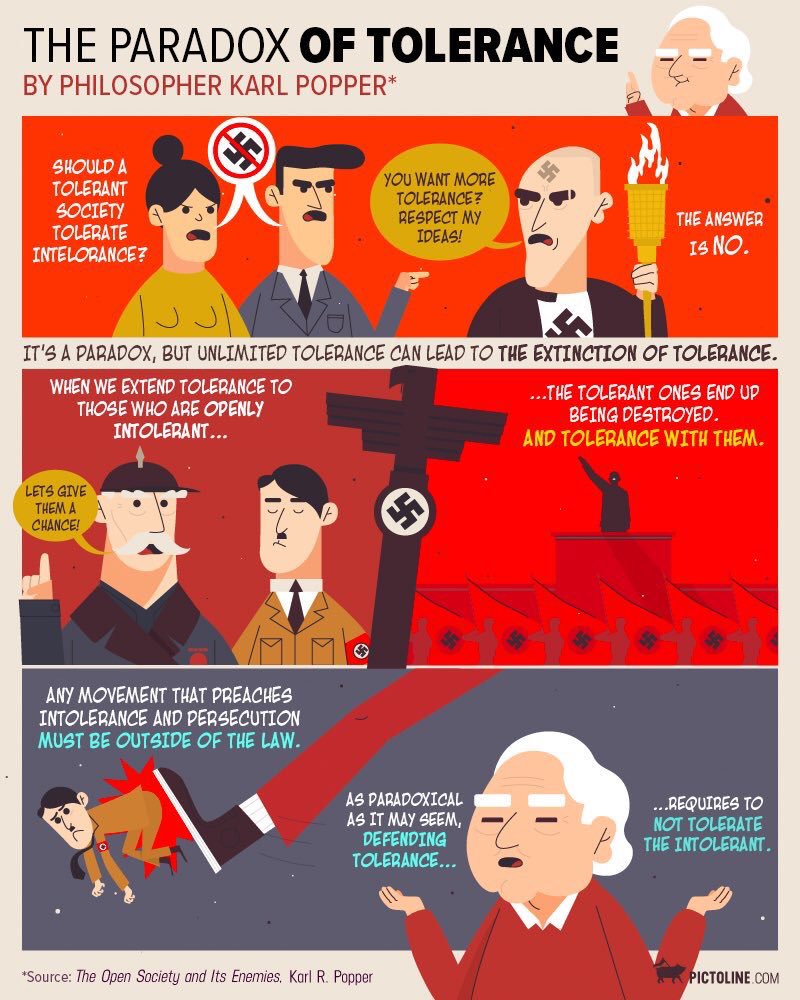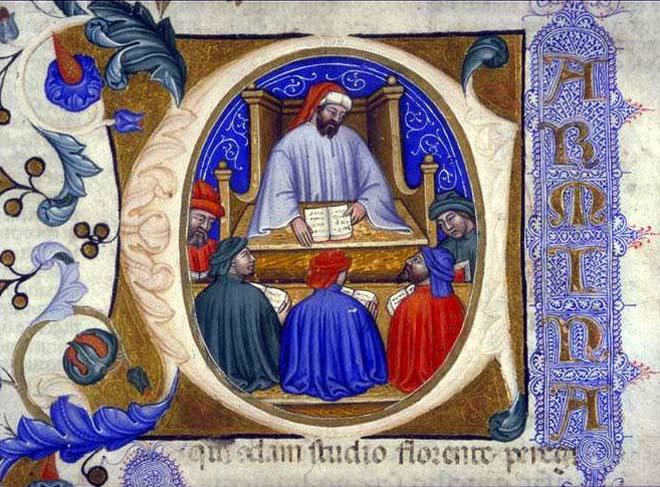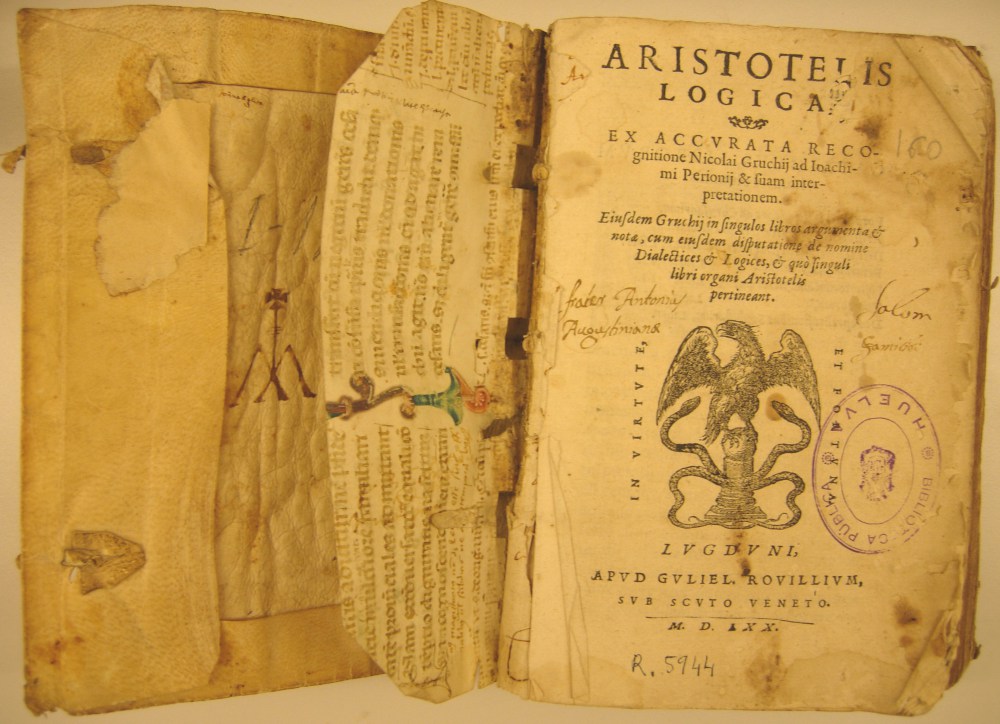Il Pensiero di Gorgia di Lentini
Gorgia di Lentini 1 rappresenta una delle figure più esemplari della sofistica nella filosofia antica. Egli fu un abilissimo oratore, fautore del relativismo conoscitivo – non diverso da quello afferente a Protagora.
Gorgia nacque verso il 485 a.C a Lentini, in Sicilia. Morì – poco probabilmente – alla longeva età di 109 anni a Larissa in Tessaglia. Nel 427 Gorgia raggiunse Atene e fu discepolo esemplare di Empedocle, professando la sua arte retorica lungo la Grecia. Tra i suoi scritti celeberrimi – che analizzeremo – ritroviamo l'”Epitaffio sui caduti in guerra”, “Sul non essere o sulla natura” e “L’encomio di Elena”.
Del non essere o della natura – I 3 Capisaldi di Gorgia
In tale scritto, Gorgia pone tre capisaldi:
- Nulla esiste.
- Se alcunché esiste, non è comprensibile all’uomo.
- Se anche fosse comprensibile, non è comunicabile agli altri.
Analizziamo cosa il filosofo voglia intendere con queste tre espressioni. Gorgia, quando asserisce che nulla esiste, non vuole intendere che il mondo che noi viviamo non esiste. Bensì, che è impossibile la pensabilità logica ed ontologica dell’essere. Egli porta avanti le sue tesi utilizzando una dimostrazione per assurdo, ovvero supponendo il contrario delle sue ipotesi.
La dimostrazione di Gorgia sul non essere
“Nulla esiste”
Gorgia sostiene che se – per assurdo – esistesse qualcosa, dovrebbero esistere o ciò che non è (1), o ciò che è (2), o entrambe le cose (3).
- Il non essere (il nulla) non è, ed in quanto “non è” non può anche “essere” allo stesso momento. Dunque, il “non è” non esiste.
- Se, invece, l’essere “è”, deve essere o eterno, o generato, o entrambe le cose. Nel caso in cui l’essere fosse eterno, sarebbe anche illimitato. Ma ciò vuol dire che esso non “è” – (non si trova) in alcun luogo specifico, dunque non esiste. Se fosse generato, dovrebbe essere frutto dell’essere, ma l’essere non è mai nato dunque non può essere generato e non può generare. Ancora, non esiste.
- In riferimento all’ultimo dei casi, l’essere non può “essere” e “non essere” contemporaneamente, poiché ciò sarebbe una contraddizione. Dunque, nulla esiste.
“Se alcunché esiste, non è comprensibile all’uomo”
Ragionando ancora per assurdo, Gorgia suppone che l’essere esista. Egli dimostra che se – ad esempio – ciò che pensiamo esiste, allora, pensando ad un asino alato – questo esiste necessariamente? Non è possibile! Dunque, ciò che è pensato non esiste, e ciò che esiste non può essere pensato. Per tale motivazione, l’essere non può essere comprensibile dalla mente umana.
“Se anche fosse comprensibile, non è comunicabile agli altri”
Continuando la dimostrazione per assurdo – se anche fosse possibile comprendere l’essere, ciò sarebbe incomunicabile. Gorgia presuppone che le cose si vedano tramite la vista e che esse si sentano tramite l’udito. Ma come faccio a comunicare con la voce e con le parole, qualcosa che ho visto? E l’interlocutore, come potrà comprendere qualcosa che ho visto, ascoltando solo le mie parole? La parola è altro dalla realtà e – allo stesso modo – il visibile non può essere espresso tramite la parola. Analogamente, l’essere – che è esterno all’uomo – non può essere comunicato tramite la parola ad altri, e dunque sarà incomunicabile.
Conclusioni
Con tali dimostrazioni per assurdo, Gorgia vuol dimostrare che la realtà astratta è nulla per l’uomo, egli non può comprenderla. Non si può parlare di concetti universali, ma solo ridurli alla specificità delle esperienze e dei pensieri che i singoli uomini e donne vivono.
Di questo modo, Gorgia non fa altro che scindere la parola – intesa come segno – da ciò cui si riferisce. Quando Gorgia parla, non comunica qualcosa né tantomeno l’essere, bensì trasmette parole. In tal modo, il linguaggio assume una potenza creativa, enfatizzante, ammaliante e chi ascolta viene colpito dal discorso, non dalla sua referenzialità.
Proponiamo qui il testo integrale della dimostrazione di Gorgia, riportato da Sesto Empirico:
Encomio di Elena (clicca per approfondire)
L’encomio tratta della vicenda di Elena che abbandonò il marito, Menelao re di Sparta, e fuggì con Paride a Troia. Questo suo gesto fu il casus belli della famosissima “Guerra di troia”. Gorgia analizza tutte le varie possibilità che hanno spinto la giovine e bella Elena a quel gesto. In tutti i casi (per volere del Caso e degli Dei; rapita per forza; convinta da discorsi eloquenti; per amore), Elena risulta senza colpa. In quanto, – in ognuno dei casi – la sua volontà fu soverchiata e soggiogata da forze superiori delle quali, lei – inerme -, non poteva far nulla.
Epitaffio
“Morti loro, non è morto con loro il rimpianto; ma vive, di loro non più vivi, in noi mortali, immortale.”
Gorgia, in questo sublime epitaffio ai caduti, mette in risalto la scelta “tragica”. Quella contraddittoria e ambivalente strada tra: il rispettare il dono divino della vita e l’adempiere alla difesa e conservazione della polis. Tale passo è un esempio della relatività gnoseologica di Gorgia sul tema della giustizia.